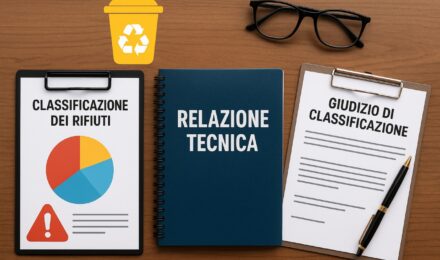Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito la regolamentazione dei rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione, con un focus sugli inquinanti emergenti e la gestione delle acque reflue.
L’aggiornamento di cui sopra coinvolge normative europee e nazionali per la tutela delle risorse idriche. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Impianti di potabilizzazione: gestione delle acque reflue e dei rilasci, le risposte del Ministero dell’Ambiente (MASE)
Il trattamento delle acque potabilizzate e i rilasci associati sono attualmente al centro di un’importante discussione normativa.
In particolar modo, la questione si è accentuata alla luce delle nuove direttive europee e delle crescenti preoccupazioni per gli inquinanti emergenti come i PFAS e le sostanze farmaceutiche.
In risposta a un interpello della Regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito un chiarimento su un tema delicato e complesso: la gestione delle acque derivanti dai processi di potabilizzazione.
Nell’ambito della revisione delle direttive europee sulle acque (2000/60/CE, 2008/105/CE e 2006/118/CE), la problematica degli inquinanti emergenti assume un ruolo centrale.
Questi includono sostanze prioritarie come i PFAS (composti perfluoroalchilici) e alcune sostanze farmaceutiche.
Questi ultimi stanno diventando sempre più preoccupanti a causa della loro persistenza nell’ambiente e dei potenziali impatti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi.
La revisione delle direttive sulle acque reflue e il regolamento europeo 2020/741 sul riutilizzo delle acque trattate si concentrano sull’aggiornamento degli standard di qualità ambientali e sulla riduzione dei rischi legati all’inquinamento.
Gli obiettivi principali di queste normative includono il miglioramento della qualità delle risorse idriche, l’adozione di pratiche sostenibili nella gestione delle acque e l’introduzione di strumenti più efficaci per il monitoraggio degli inquinanti.
L’applicazione del principio “chi inquina paga” rappresenta un passo avanti cruciale, poiché garantisce che i responsabili dell’inquinamento, comprese le aziende che gestiscono impianti di trattamento delle acque, siano tenuti a sostenere i costi della depurazione.
Impianti di potabilizzazione: gestione del “depurato” e del “concentrato”
La Regione Lazio ha sollevato una questione tecnica riguardante il trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, chiedendo chiarimenti sulla gestione dei rilasci di acqua trattata.
In particolare, la domanda riguardava se le acque derivanti dal trattamento di potabilizzazione, contenenti elementi naturali in concentrazione più elevata rispetto a prima del trattamento, debbano essere considerate come rilasci soggetti a regolamentazione.
Il Ministero dell’Ambiente ha risposto facendo riferimento all’art. 114 del d.lgs. 152/2006. Quest’ultimo assegna alle Regioni la competenza di disciplinare la restituzione delle acque utilizzate negli impianti di potabilizzazione, con il parere del MASE.
Nel dettaglio, il Ministero ha confermato quanto chiarito dalla Regione Lazio, distinguendo tra il “depurato” e il “concentrato” prodotti dal processo di potabilizzazione, ad esempio attraverso l’osmosi inversa.
Il “depurato” è l’acqua trattata che, quando non è richiesta dalla rete di distribuzione, può essere rilasciata in un corpo idrico senza necessità di autorizzazione, poiché non rappresenta un rischio per l’ambiente.
Al contrario, il “concentrato”, ovvero il residuo che contiene elevate concentrazioni di sostanze rimosse durante il trattamento, è considerato uno scarico. Pertanto, deve rispettare rigorosi limiti normativi per evitare di alterare la qualità del corpo idrico ricevente.
La normativa sulla restituzione delle acque
La legislazione italiana sulla gestione delle acque è ben delineata nel d.lgs. 152/2006, che definisce le regole per la tutela delle risorse idriche. L’art. 114 di questo decreto si occupa specificamente della restituzione delle acque derivanti dal processo di potabilizzazione.
La distinzione tra “rilascio” e “scarico” è fondamentale per determinare se un determinato flusso d’acqua richiede o meno un’autorizzazione.
Nel caso del “rilascio” del “depurato”, poiché l’acqua è considerata priva di elementi inquinanti in concentrazioni pericolose, non è necessaria alcuna autorizzazione.
Tuttavia, per il “concentrato”, che contiene sostanze inquinanti in concentrazioni elevate, è obbligatoria l’autorizzazione allo scarico.
Questo approccio normativo garantisce una gestione più sostenibile delle risorse idriche e aiuta a prevenire il degrado dei corpi idrici naturali, specialmente nei casi in cui le sostanze rilasciate potrebbero avere un impatto negativo sugli ecosistemi.
Inoltre, l’obbligo di rispettare i limiti imposti dalle tabelle dell’allegato V del d.lgs. 152/2006 per gli scarichi permette di monitorare e controllare in modo efficace la qualità dell’acqua rilasciata.
Un altro aspetto cruciale discusso dal MASE, come accennato, è l’applicazione del principio “chi inquina paga”, già previsto dalle normative europee e italiane.
Questo principio si traduce in una responsabilità estesa del produttore (EPR) per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue.
Le aziende che gestiscono impianti di potabilizzazione o di trattamento delle acque reflue devono farsi carico dei costi di depurazione.
Nello specifico quando si tratta di sostanze pericolose come i PFAS o le sostanze farmaceutiche, che richiedono trattamenti avanzati per essere rimosse dall’acqua.
L’introduzione di questo principio è fondamentale per garantire che i soggetti responsabili dell’inquinamento adottino misure preventive e correttive adeguate.
La gestione del rischio legato agli inquinanti emergenti diventa così una priorità sia per le autorità regolatorie che per le imprese, che devono investire in tecnologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività.