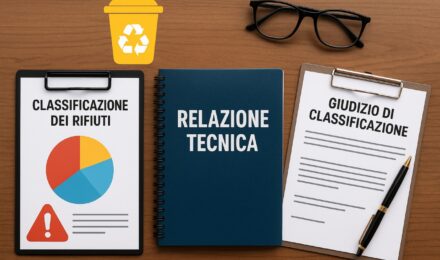Il fast fashion, diffuso globalmente, ha gravi conseguenze ambientali, sociali e a livello di inquinamento, dalla produzione in condizioni degradanti alla discarica dei capi invenduti. Ma cosa significa esattamente?
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Inquinamento e sfruttamento lungo la catena di approvvigionamento: il fenomeno globale del fast fashion
Il fenomeno del fast fashion, nato negli anni ’90 e ormai diffuso in tutto il mondo, ha trasformato il settore della moda in un mercato basato sulla velocità e sulla convenienza a scapito dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.
Questa tendenza, incentivata dalle catene di abbigliamento che propongono collezioni a basso costo ispirate ai trend più recenti, è diventata una delle principali cause di inquinamento globale e di sfruttamento lavorativo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.
Il termine “fast fashion” si riferisce a un modello produttivo che promuove la creazione continua di abiti economici e di bassa qualità, con cicli di produzione rapidi e brevi.
Questo approccio mira a soddisfare una domanda sempre più orientata verso il consumo veloce e l’usa e getta. Tuttavia, questa modalità ha un costo ambientale e umano elevato.
Gran parte della produzione di abbigliamento avviene in Asia, in paesi come il Bangladesh e la Cina, dove il rispetto delle normative ambientali e lavorative è spesso insufficiente.
Il Bangladesh, in particolare, è uno dei principali centri di produzione di abbigliamento a livello mondiale, ma questo primato si accompagna a enormi problemi ambientali e sociali.
Le fabbriche, spesso denominate sweatshop, operano in condizioni di lavoro precarie, con salari bassi e turni massacranti.
I lavoratori, tra cui molti bambini, sono esposti quotidianamente a sostanze chimiche tossiche utilizzate per la produzione di tessuti, come coloranti e detergenti che vengono poi rilasciati nei fiumi e nei canali, contaminando le risorse idriche locali.
Uno degli esempi più eclatanti è il fiume Turag, vicino a Dhaka, in Bangladesh, che ha subito gravi danni ambientali a causa degli scarichi industriali delle fabbriche tessili.
Questo livello di inquinamento ha conseguenze devastanti per le comunità locali, che dipendono dall’acqua per la loro sopravvivenza, sia per l’agricoltura che per l’uso quotidiano.
Inoltre, la contaminazione dei fiumi contribuisce alla distruzione degli ecosistemi fluviali, portando all’estinzione di numerose specie acquatiche.
Lo sfruttamento lavorativo e i costi umani del fast fashion
In Cina, dove le condizioni lavorative sono relativamente più controllate rispetto ad altri paesi asiatici, il problema principale riguarda l’uso di sostanze chimiche pericolose nei processi produttivi.
Un recente studio condotto da una rivista tedesca ha rilevato che molti capi venduti da grandi catene di fast fashion contenevano metalli pesanti e ftalati, sostanze altamente tossiche e vietate in gran parte dell’Europa.
Queste sostanze possono provocare gravi problemi di salute sia ai lavoratori che ai consumatori finali.
Oltre all’inquinamento ambientale, il fast fashion perpetua uno sfruttamento sistematico dei lavoratori. Le fabbriche, spesso situate in paesi con legislazioni lavorative deboli o inesistenti, offrono salari estremamente bassi e condizioni di lavoro disumane.
Gli operai, tra cui molte donne e bambini, sono costretti a lavorare per lunghe ore in ambienti pericolosi, senza protezioni adeguate contro le sostanze chimiche e i macchinari pesanti.
La pressione per mantenere i costi di produzione bassi spinge le aziende a ignorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, concentrandosi unicamente sul profitto.
Questo modello di business ha reso il fast fashion una delle industrie più redditizie al mondo, ma a un costo umano altissimo.
Le storie di incidenti e violazioni dei diritti umani nelle fabbriche tessili sono numerose. Solo negli ultimi anni hanno iniziato a emergere con maggiore forza grazie alle campagne di sensibilizzazione globali.
Il ciclo dei rifiuti e le discariche abusive
Una delle conseguenze più visibili del fast fashion è la creazione di enormi quantità di rifiuti tessili. I capi prodotti sono spesso di scarsa qualità e seguono tendenze di breve durata, il che significa che finiscono rapidamente tra i rifiuti.
Questo problema è aggravato dalla sovrapproduzione: si stima che molte grandi catene arrivino a produrre fino al 40% in più di quanto richiesto dal mercato.
I capi invenduti vengono spesso smaltiti in discariche illegali, contribuendo ulteriormente alla crisi ambientale.
Un esempio emblematico è il mercato di Kantamanto, ad Accra, in Ghana, il più grande mercato di abbigliamento di seconda mano in Africa. Qui, tonnellate di vestiti scartati dai paesi occidentali arrivano ogni giorno, molti dei quali in pessime condizioni.
Questi vestiti, chiamati “obroni wawu o “vestiti degli uomini bianchi morti”, vengono rivenduti a basso costo, ma una parte significativa finisce nelle discariche, creando un enorme problema ambientale per il paese.
Simili scenari si ripetono anche in Sud America, dove le discariche abusive sono diventate una realtà preoccupante. Nel deserto di Atacama, in Cile, è nata una delle più grandi discariche di abbigliamento al mondo.
Migliaia di tonnellate di vestiti scartati si accumulano nel deserto, formando veri e propri “cimiteri del fast fashion”.
Questi rifiuti, spesso non biodegradabili, rappresentano una minaccia per l’ambiente e la salute pubblica. Oltre a testimoniare l’enorme spreco di risorse che caratterizza il settore della moda usa e getta.
In altre parole, il fast fashion ha un impatto devastante a livello globale, sia dal punto di vista ambientale che umano. Tuttavia, esistono alternative sostenibili che possono ridurre questi effetti negativi.
Un numero crescente di marchi sta cercando di adottare pratiche più etiche e rispettose dell’ambiente, come l’uso di materiali riciclati e una maggiore trasparenza nelle catene di produzione.